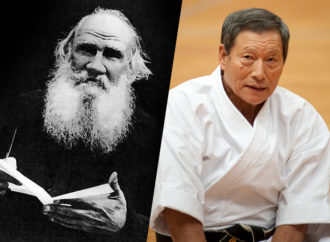Se torno col pensiero ai miei primi dieci anni di karate, trovo che il programma di oggi sia molto più vario, tecnicamente più complesso, ma meno “duro”.
Venerdì 13 luglio si è ufficialmente concluso il mio 53° anno di pratica del karate, nel dojo di quello che è stato anche il mio primo maestro, Carlo Fugazza. In questi ultimi tempi sto cercando di allenarmi con maggiore frequenza per compensare un calo, penso fisiologico, di alcune qualità fisiche che avevano caratterizzato la mia pratica da giovane, in particolare la rapidità e la scioltezza articolare. Quest’anno ho perso un mese di allenamento per un’infezione batterica alle gambe, che per fortuna non ha lasciato strascichi se non estetici, ma ho ripreso senza problemi particolari.
La vera novità di quest’anno è stata la frequenza regolare a due corsi diversi, ciascuno con una sua anima, che ho imparato a conoscere e rispettare: il martedì-venerdì ore 18-19, che è rimasto il mio corso di elezione, col “mio” quadratino sul tatami dove fare tai-so e il “mio” posto in prima fila sulla scacchiera al momento dell’inizio. Ad esso si è aggiunto ufficialmente il lunedì-giovedì ore 20-21, un orario inizialmente a me poco gradito perché “a noi anziani piace cenare presto”.
A rotazione vengono allenati tutti i 26 kata dello Shotokan.
Essendo un “outsider”, in questo secondo corso (che fa riscaldamento in corridoio, perché il tatami l’ora prima è occupato dal corso 19-20 del maestro Cardinale) non ho un posto fisso, ma umilmente resto in fondo alla sala, con lo svantaggio di non sentire bene i comandi del maestro. Il quale, essendo incerto se io sia solo un po’ sordo o anche duro di comprendonio, ripete spesso le istruzioni, guardandomi fisso e aspettando evidentemente un mio cenno di consenso prima di procedere.
Al martedì-venerdì l’atmosfera è molto seria, ci sono numerosi ex agonisti e settimi Dan, e il mio compagno-quasi-fisso di allenamento non mi concede di sgarrare un attimo, richiamandomi se mi distraggo o dimostrandomi nella pratica l’inefficacia delle mie parate e dei miei spostamenti. Devo senz’altro anche a lui e al suo esempio l’impegno costante che metto nell’allenamento, anche se i risultati lasciano a desiderare. Al venerdì spesso il maestro è chiamato a qualche impegno nazionale o internazionale, ma Vittorio lo sostituisce degnamente.
Tutt’altra musica al lunedì-giovedì: la clientela è più varia, i gradi anche, e il corso è ingentilito dalla presenza di numerose leggiadre fanciulle (di età varia, ma tutte leggiadre!), agguerrite ma perennemente di buonumore, il che non può non avere un effetto ingentilente anche sul mood del maestro (che comunque dei miei difetti non si dimentica mai).
Il programma è simile in entrambi i corsi e in linea di massima rispetta il principio delle tre “k”: si comincia quasi sempre con i fondamentali, non necessariamente il kihon federale richiesto per il passaggio di grado, ma libere variazioni che comprendono le principali tecniche di braccia e di gambe. Molto spesso questi fondamentali avanzati si rivelano tecniche di kumite, che vengono successivamente allenate in coppia, spesso alternando i ruoli di attaccante e difensore secondo il principio di nidan-henka. Un vero rompicapo per gli zucconi come me…
L’ultima parte della lezione è dedicata ai kata: a rotazione vengono allenati tutti i 26 kata dello Shotokan, con l’enfasi che si sposta sui kata richiesti per una particolare circostanza (un passaggio di Dan, la presenza di ospiti nel dojo…). Non manca quasi mai la ripresa del bunkai di uno o più kata, parziale o integrale, in una delle forme sempre più complesse elaborate in questi decenni dal maestro Shirai. Il bunkai, che all’inizio mi stava antipatico (lo chiamavo “il kata del kata”) mi ha definitivamente conquistato, tanto che già da alcuni anni seguo la lezione mensile in una palestra di Monza (e la settimana successiva faccio compassione a chi mi vede muovermi…)
Non manca quasi mai la ripresa del bunkai di uno o più kata, parziale o integrale.
Se torno col pensiero ai miei primi dieci anni di karate, trovo che il programma di oggi sia molto più vario, tecnicamente più complesso, ma meno “duro”: non nel senso della severità dell’impegno richiesto, ma del senso di “pericolo” che mi accompagnava, allora ventenne, alle lezioni. Sarà stato per il jiyu kumite semi-clandestino che praticavamo invece del tai-so prima delle lezioni, per il rumore di sottofondo dei makiwara percossi nel corridoio di via Bezzecca, per i “kiai” laceranti che ci accoglievano e per la voglia di primeggiare tipica dei giovani.
Tutto questo oggi non c’è, non so se lo reggerei o se ne sento la mancanza. Siamo tutti più timidi e rispettosi (e forse anche più timorosi delle conseguenze del nostro comportamento).
Non c’è ansia particolare in me quando suono il campanello e varco la soglia del dojo, se non forse la preoccupazione di non deludere il mio maestro e di essere un buon sparring-partner per il mio amico Emilio. Ancora per l’anno prossimo, poi si vedrà…