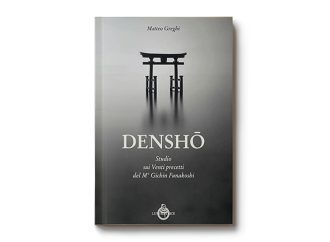Aumentando il nostro livello tramite un’arte e sotto la guida di un buon maestro che ci fa percorrere il Do, possiamo aumentare la nostra capacità di giudizio e spostarla in avanti, all’infinito.
(in Karate Do n. 7 lug-ago-set 2007)
La dinastia Tang fu molto importante nella storia cinese, spicca per la prosperità economica e la stabilità sociale, ma anche la cultura e l’arte registrarono splendidi successi.
In particolare, la poesia dell’epoca Tang (618-907 d.C.) è nota come una delle più alte manifestazioni dello spirito umano, si distinse in diversi periodi:
Nel primo (618-712) i cosiddetti “geni” Wang Bo, Yang Jiong, Lu Zhaoling e Luo Binwang, conclusero il processo della resa in rima delle poesie. Grazie ai loro sforzi, il tema delle poesie lasciò lo sfarzo dei palazzi imperiali per la vita ordinaria.
Il secondo periodo (712-762) fu quello del massimo splendore, con una gran ricchezza di contenuti e canti alla natura, alle zone di frontiera, all’eroismo. I poeti più famosi furono: Li Bai, Du Fu, Wang Wei, Ming Haoran, Gao Shi, Chen Shen e così via.
Il periodo seguente (762-827) vide poeti come: Bai Juyi, Li He, Yuan Chen; Bai Juyi fu molto apprezzato dai lettori perché si sforzò di avere un linguaggio popolare e scorrevole, si distinse per il suo attacco ai nobili, opponendosi alle guerre e ironizzando sulle pesanti tasse. Nel tardo periodo brillarono Li Shangyin e Du Mu.
Le poesie Tang sono tuttora utilizzate nello Shodo, come studio degli antichi ai quali fare riferimento e come prove d’esame per l’ottenimento dei dan.
La produzione letteraria dei Tang si trova raccolta in due grandi collezioni compilate per decreto imperiale nel XVIII secolo: il Quantangshi (tutta la poesia Tang), con circa cinquantamila poesie di duemila e duecento autori, ed il Quantangwen (tutta la prosa Tang).
Le poesie Tang sono tuttora utilizzate nello Shodo, come studio degli antichi ai quali fare riferimento e come prove d’esame per l’ottenimento dei dan.
A proposito di questo vorrei raccontare un aneddoto da me vissuto durante il corso di shodo.
Appena consegnata la prova d’esame per il 1° kyu, chiesi al M° Nagayama a cosa mi sarei dovuto dedicare ora. “Facciamo poesia! Scegli tra una di queste!” mi disse. Fino ad allora avevo lavorato su fogli piccoli (25×35), ma avevo già visto alcuni più anziani di me lavorare a terra su fogli lunghi (135×35), quelle erano le poesie. Il maestro mi fece vedere un libro di poesie cinesi dell’epoca Tang, ne avrei dovuta scegliere una da eseguire in kaisho, ma quale criterio dovevo usare? “Una che ti piace!” disse con un sorriso… e si girò.
Cominciai a sfogliare questa raccolta, i nomi degli autori erano per me sconosciuti, mi sembravano tutte belle, capii che dovevo utilizzare l’istinto. Sfogliando, l’occhio si fermò in particolare su una… Rifeci il giro, ma tornai a fermarmi sulla medesima… è questa allora!
La feci vedere al maestro che, ovviamente, non espresse nessun giudizio “A te piace? Bene, allora comincia a studiare”…e si voltò.
Erano venti ideogrammi allineati su due colonne, qualcuno conosciuto e tanti no, qualcuno semplice e altri più complessi. Come studiare? Con quale metodo? Mi comportai allora come quando devo affrontare ogni cosa difficoltosa: Ma io faccio karate! mi dico. Quando ho lavorato su di un unico ideogramma non era come fare il kihon? E quando facevo le prove d’esame con quattro ideogrammi, non era come una combinazione? Quindi cosa raffigurava la poesia se non un kata?
E come ho imparato i kata se non prima “copiando“ per apprendere lo schema generale e poi accorgermi che molti passaggi erano così difficoltosi da doverli affrontare singolarmente e ripeterli tante, tante volte, fino a sentirli più sicuri e infine riprovare il tutto insieme e così via?
Ugualmente feci allora: stesi un foglio a terra e di fianco la poesia da copiare, cercai una buona posizione e iniziai a mettere sul foglio quello che i miei occhi vedevano (più correttamente, quello che i miei occhi acerbi, con tutta la loro ignoranza, credevano di vedere!). Per molte volte non riuscii nemmeno ad arrivare in fondo alla prima colonna, scrivevo così in grande che terminavo lo spazio prima del tempo, e via da capo, poi me ne accorgevo a metà e cominciavo a rimpicciolire per riuscire a starci, guardandolo, sembrava uno di quei cartelli monitori scritti a mano su cartone, nei cantieri edili in costruzione: “VieTATO l’acCesso”… tanto orribile da non far entrare nessuno per la paura!
Anche la mia poesia era orribile, le due colonne sembravano due serpenti. Guardandoli uno per uno, qualche ideogramma poteva anche essere “decente”, ma molti erano proprio terrificanti e allora, un’altra e un’altra prova ancora, fino a che non esaurivo le energie.
A volte, a metà di un’esecuzione, accorgendomi di un errore, perdevo la concentrazione e quindi cominciavo ad accelerare per finire, mandando tutto a rotoli. (Non viene in mente il Kankudai, quando a metà ci manca il fiato, ci prende il panico e ci viene da correre per finire prima possibile?!).
Il maestro guardava e andava oltre senza dir nulla. Mi sentivo frustrato e ripensavo ai miei allievi, a quando facevamo un kata nuovo. Si lamentavano insoddisfatti perché non capivano e io non sapevo che altro dir loro, se non di riprovare e ripetere, sino a quando non l’avessero memorizzato, solo a quel punto avremmo cominciato a studiare seriamente.
Il maestro guardava e andava oltre senza dir nulla. Mi sentivo frustrato e ripensavo ai miei allievi, a quando facevamo un kata nuovo.
Dopo diverse lezioni, dove ammassavo fogli su fogli, i venti kanji erano ancora bruttini, ma almeno erano incolonnati e allineati, in più, avevo memorizzato la sequenza. Il maestro cominciò a mostrare più attenzione, mi fece lui un esempio della poesia per lavorare su quello, capii che aveva fatto da ponte tra l’autore (Wang Wei) e me, eseguendo la poesia, non con la maestria che possedeva, ma abbassandosi al livello che avrei dovuto raggiungere io (del resto non mi comporto così anch’io quando faccio vedere una tecnica a un principiante?).
Alternai allora esecuzioni complete, allo studio ripetuto di quegli ideogrammi che vedevo più deficitari, cercai anche di tradurre la poesia per capirne il significato e rintracciai qualcosa sull’autore, sempre per capire meglio. La maggior parte del lavoro sembrava fatta, ma, invece, era proprio ora che si cominciava davvero!
Il maestro mi dava dettagli sempre più precisi, ma complessi, da capire. Trascorsi quasi un anno su questa poesia, amandola, ma tante volte odiandola. Finalmente il maestro ne accettò una da spedire in Giappone per essere esaminata, fu ritenuta idonea e due mesi dopo mi arrivò il diploma di “Junshodan” (che significherebbe pre-dan). La poesia era cresciuta e io con lei.
Anche nel kata c’è questa catena: qualcuno ha creato uno schema originale, che viene tramandato “immutato” da maestro ad allievo, sino a quando il “nostro” maestro lo insegna a noi, creando così quel ponte tra autore ed esecutore, senza il quale non sarebbe possibile comprendere ciò che si sta facendo.
Spesso si pensa che chiunque possa sentirsi in diritto di esprimere giudizi su ogni cosa, per il solo fatto che è un “essere pensante”, ma soltanto chi sta percorrendo un Do può rendersi conto che i nostri occhi, la nostra mente, vedono solamente ciò che il livello di quel momento ci fa vedere. Aumentando il nostro livello, tramite un’arte e sotto la guida di un buon maestro che ci fa percorrere la Via passo per passo, possiamo aumentare la nostra capacità di giudizio e spostarla in avanti, all’infinito.

Fig. 1

Fig. 2
NOTE
Tang in giapponese si legge To o kara, chi si è interessato alla storia del karate si ricorderà che quest’arte, a Okinawa fu dapprima chiamata Tode (mano cinese, impiegando il nome della dinastia), fino a quando il M° Funakoshi, utilizzando la seconda lettura (kara), la fece diventare karate (mano vuota), sostituendo l’ideogramma kara di Cina (fig. 1) con kara di vuoto (fig. 2) dando così al nome una connotazione più filosofica.